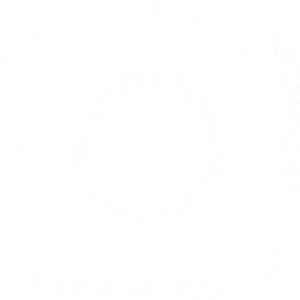intervista a gruppo Ippolita e Marta Palvarini
a cura di Matteo Gaspari

Tra luoghi comuni e pregiudizi, il videogioco è spesso guardato con sospetto, nonostante la sua crescente popolarità e le sue potenzialità comunicative e narrative. Abbiamo intervistato il gruppo Ippolita – gruppo di ricerca indipendente e interdisciplinare che si occupa di tecnologie digitali e filosofia della tecnica – e Marta Palvarini – scrittrice, esperta di game studies e collaboratrice di Ippolita – per esplorare l’origine e il persistere di queste malinterpretazioni, ma anche per indagare le potenzialità di questo linguaggio.
—
Il videogioco è la più grande industria dell’intrattenimento del pianeta, eppure la consapevolezza media del suo valore e delle sue potenzialità passa ancora attraverso una serie radicata di pregiudizi. Come mai è così raro che il videogioco venga letto come prodotto culturale?
L’utenza media del videogioco stimata, secondo i calcoli più aggiornati, è di 3 miliardi di persone, di cui il 50% risiede in Asia. Sul totale il 50% gioca solo su mobile, e il resto su PC (nella categoria PC sono incluse le consolle, che hanno una percentuale dell’8% sul totale ma anche la spesa più alta per singolo utente sui titoli in uscita).
Il videogioco storicamente è stato letto come strumento di evasione dalla realtà. Molti giochi arcade non avevano una trama o una narrazione: erano puro gameplay, gioco senza alcuna pretesa di narrare storie. Già con le prime avventure narrative a schermo (Zork I, del 1980) il genere prende vita sullo schermo dei PC ma, fino agli anni Novanta, l’home gaming (l’abitudine di giocare a casa propria, con una consolle) non viene analizzato dai mass media e si focalizza invece l’attenzione sul gioco “da sala giochi” che, per esigenze di mercato e di funzione, non ha una trama specifica.
Il problema persiste tutt’oggi nella stampa generalista. Il focus è posto ora sui giochi dal linguaggio meno narrativo ma “dall’ampio impatto sociale”. Si può citare Fortnite come esempio massimo di distorsione giornalistica: dagli articoli di cronaca nera che includono minori morti “a causa del videogioco”, alle stime economiche del capitale di Epic Games, l’azienda produttrice di Fortnite. Non si citano mai, per esempio, il gameplay innovativo o lo sfruttamento degli sviluppatori da parte di Epic Games.
Al di fuori della stampa di settore non si parla di videogiochi in termini tecnici, ma scandalistici: questo è il motivo per cui non sono presi in considerazione come prodotti culturali o anche solo come medium di serie A. In tutti gli altri ambiti invece, dall’accademia con i suoi dipartimenti internazionali di game studies, ai governi più attenti alle nuove tecnologie, di videogioco e del suo linguaggio si parla molto, e con estrema attenzione. La domanda quindi sorge spontanea: chi considera il videogioco un medium di serie B? Probabilmente i restanti 5 miliardi (o poco meno) di popolazione mondiale che non gioca ai videogiochi.
Ma generalizzare intendendo tutti i videogiochi come linguaggio di serie B allontana da una possibile riflessione critica. Quello che non è chiaro forse sta al di là dei grandi fatturati, dove il videogioco non è ridotto a puro intrattenimento. Chi di noi non gioca mai? Nel corso della giornata passiamo buona parte del nostro tempo a giocare, che sia con un’app da smartphone o con una game station. Il videogioco è alla portata di tutti e tutte (più o meno, visti i costi). Ecco, diciamo allora che la differenza la fa il tipo di videogioco, o addirittura il singolo titolo. Pensiamo a quanto si apre la forbice tra due giochi diversissimi come Candy Crush e The Stanley Parable, giusto per portare due esempi agli estremi: da una parte la risposta pedissequa a stimoli del gioco, dall’altra la trasgressione che crea nuove possibilità all’interno della narrazione. Magari ci sono videogiochi di qualità dubbia, o che consideriamo tali, come i cosiddetti busywork che si basano sul puro intrattenimento procedurale, che fanno davvero parte dell’intorpidimento industriale che dobbiamo rifiutare. E poi ci sono altri prodotti, senza arrivare per forza all’edutainment (intrattenimento educativo), che hanno ambizioni diverse e non si appiattiscono nella monotonia dei loop generati da facili ricompense.
—
Il videogioco è spesso descritto come pericoloso, come mai?
L’immedesimazione, nel videogioco così come nel gioco di ruolo, è fondamentale nell’interazione con il medium. L’immedesimazione su schermo richiama il sentimento collettivo di escapismo e di allontanamento dalla realtà, frutto di decenni in cui lo stesso trattamento veniva applicato alla televisione. Probabilmente è proprio il modo di fruizione del videogioco, “a schermo”, a richiamare il sentimento di “pericolo culturale”, senza considerare l’evoluzione di ciò che passa sullo schermo stesso. L’attenzione, quindi, è riservata più alla fruizione materiale che al contenuto.
La questione morale riflette la questione dell’immedesimazione come possibilità di emulazione nella “vita reale”, una questione peraltro non supportata da ricerche scientifiche ma sempre dai soliti fumosi articoli di cronaca nera che coinvolgono minori o giovani.
A causa di questi fattori non si pone quindi attenzione alla realtà del videogioco oggi, alle sue capacità narrative considerate da molti scrittori e scrittrici al pari dei romanzi, alla sua profondità di elaborazione socio-politica, presa in esame da accademici di ogni campo. Come prima, il videogioco va considerato un medium vero e proprio, bisogna sperimentare e metterci le mani.
E forse non è poi così vero che il videogioco non è considerato un prodotto culturale complesso e rilevante. Anche qui dobbiamo ricordare che ci sono giochi e giochi, e che semmai ci fosse una narrazione dominante che descrive la categoria “videogiochi” come un potenziale pericolo possiamo trovare molti esempi che ci dicono esattamente il contrario. Il videogioco viene usato per esempio per far capire a bambine e bambini con patologie come affrontare la propria malattia. E non è un caso che i videogiochi siano usati anche in contesti educativi per la possibilità che offrono di sperimentare narrazioni e simulare contesti di apprendimento. Quello su cui è necessario riflettere, semmai, sono le strutture su cui si basano i videogiochi stessi, specie negli ambienti educativi, pensando sempre che il modo in cui vengono raggiungi certi risultati è molto più importante dei risultati stessi. Giocare va bene, videogiocare anche, gamificare –cioè inserire a tappeto elementi tipici dei giochi competitivi come premi, classifiche, eccetera in contesti di non-gioco – su tutte le nostre attività per renderle più accattivanti, no.
—
Per continuare a smontare pregiudizi e preconcetti, ai videogiochi si guarda spesso con preoccupazione per quanto riguarda contenuti violenti e contesti di abuso, e in generale di un uso poco consapevole.
Non ci sono prove che il videogioco causi “violenza”, anzi. Ovviamente l’abuso del gioco, come l’abuso di televisione o la tendenza a considerare i libri come “realtà”, può portare a problematiche psico-fisiche, spesso correlate con fragilità pregresse, in genere non diagnosticate. Cerchiamo sempre di mantenere un approccio antiproibizionista. Non moralizziamo il piacere. Non c’è niente di male nel fare una sessione di gioco lunga ore; certo, può essere un’esperienza al limite, ma non deve essere negata. C’è chi legge o studia per ore, chi corre per chilometri… ognuno ricerca le proprie fonti di piacere. Se questa ricerca è cosciente, se so dove sono e cosa sto facendo, allora va bene. Non bisogna mai perdere la consapevolezza, problematizzando continuamente le scelte che si fanno. Evitiamo una fruizione passiva, questo sì. E facciamo attenzione: se pensiamo ad esempio al grande gioco competitivo dei social network commerciali cerchiamo di capire quanto, invece di agire, reagiamo ai continui stimoli delle interfacce. Con i videogiochi è lo stesso: più complessa sarà l’esperienza che cerchiamo e meno vorremo lasciare che faccia tutto il gioco. Meglio agire che reagire a una sequenza di stimoli dell’interfaccia.
In ogni caso, subentra la dimensione individuale e del vissuto personale, con anche le fragilità e vulnerabilità del caso, che potrebbero portare a situazioni di evasione dalla socialità, di identificazione con il proprio avatar al limite della psicosi, eccetera. Ci sono casi limite di usi al limite. Molti studi ed esperienze dirette però sottolineano come alcuni videogiochi favoriscano nuove declinazioni della socialità, o permettano di sperimentare – e, perché no, allenare – le nostre abilità cognitive, di problem solving, di concentrazione.
—
Mi sembra che la questione centrale sia quella della consapevolezza. Com’è possibile stimolarla, soprattutto tra chi non si è mai avvicinato ai videogiochi?
La stampa di settore usa una terminologia per nulla complessa e variegata, al punto da poter essere utilizzata come ottimo metodo di diffusione di consapevolezza. I toni di questa stampa settoriale possono variare dal semplice-generico-introduttivo, al tecnico-scientifico, al politico-sociale, fino allo psicologico e all’economico. La diffusione di figure come streamer di settore, persone che giocano ai videogiochi in diretta sui loro canali YouTube o Twitch, è un buon modo per approcciarsi alla consapevolezza, guardando con i propri occhi l’attività di gioco da spettatori e spettatrici. Ma purtroppo lo scetticismo più radicato si può decostruire unicamente attraverso l’attività ludica in prima persona, e i videogiochi narrativi sono quelli che meglio si adattano a questo scopo, non necessitando di capacità tecniche o particolari abilità per proseguire in una narrazione a bivi.
E comunque giochiamo assieme! Il co-playing può essere un modo per comprendere che cosa spinge chi gioca a giocare. L’esempio più diretto è il co-playing all’interno dei nuclei familiari: stimola nuove forme di apprendimento condiviso anche per chi non gioca e permette di entrare in contatto con la dimensione emotiva che coinvolge i giocatori e le giocatrici.
—
Come gruppo di ricerca indipendente, quali sono le maggiori difficoltà che incontrate nell’educazione alla tecnologia? Trovate che i videogiochi abbiano un ruolo rilevante nella fruizione digitale della contemporaneità?
Noi cerchiamo di problematizzare il rapporto che abbiamo con la tecnologia, la nostra critica si rivolge in particolare alle tecnologie commerciali. Una delle difficoltà maggiori sta nel riuscire a scardinare tutti gli automatismi che le interfacce commerciali generano in noi, spingendo le varie forme di delega cognitiva, tecnica, politica. Ecco, proprio in questo arriviamo alla radice del termine educare, tirar fuori: facciamo emergere a livello cosciente una serie di protocolli che influiscono e direzionano le relazioni che instauriamo con i dispositivi. Lo facciamo in gruppo, ognuno portando la propria esperienza, e cerchiamo di capire che margini abbiamo per ristabilire la nostra autonomia all’interno della relazione con il mondo macchinico. Partendo dalle esigenze di ognuno e ognuna di noi.
I videogiochi sono uno degli strumenti migliori per spiegare il mondo reale, poiché attraverso di essi si generano dinamiche uniche che spiegano alla perfezione i concetti socio-economico-politici alla base della nostra società. La contemporaneità è fortemente digitalizzata e allo stesso tempo gamificata: l’utilizzo massivo delle strategie di gamification del reale attraverso app che inseriscono dinamiche di gratificazione immediata o progressiva, proprie del videogioco, rientrano nella “biopolitica dei corpi” e del loro controllo.
—
Quali credete che siano le maggiori potenzialità del videogioco come linguaggio e oggetto culturale?
Il videogioco permette di influenzare il corso degli eventi narrati in tempo reale, in una moltitudine di possibilità narrative che non sono trascrivibili, ad esempio, su carta. È un linguaggio che permette anche di vestire i panni di altre persone: impersonare un avatar che ci rispecchia in tutto e per tutto non è mai possibile poiché è il contesto a definire chi siamo. La personificazione varia da gioco a gioco, ma in ogni caso, che si stia interpretando una miliardaria con una mega villa in The Sims o l’eroica Lara Croft, il videogioco ci fa vivere “le vite degli altri”, e delle altre.
La scoperta di ogni filone narrativo dettato dalle scelte della persona giocante, così come l’interpretazione in prima o terza persona di un personaggio che non è la persona giocante, permette una fruibilità e una longevità del singolo prodotto immensa e sfaccettata. E se in quel bivio avessi scelto A invece che B? E se mi fossi comportata in questo modo? Come reagirà il mio personaggio a questo avvenimento? Dove mi condurrà la trama? Sono solo alcune delle interminabili domande che ci si pone videogiocando.
—
Negli ultimi anni quali sono state le principali conquiste del videogioco in termini culturali e narrativi?
L’ultima annata videoludica ha fornito capolavori della narrazione, esempi sicuramente migliorabili ma unici. La rappresentazione della diversità e dell’alterità culturale, e la totale libertà di azione all’interno di mondi virtuale, così come la potenza dei messaggi impliciti, possono solo evolvere in un medium che non sembra fermarsi di fronte ad alcuna barriera costruita su preconcetti e tabù.
Qualche esempio: grazie a giochi complessi come Death Stranding abbiamo visto come gioco e narrazione si sono fusi alla perfezione per trasmettere un immaginario filosofico. Questo titolo elabora filosoficamente esistenzialismo, automazione, gamification (a partire da Huizinga fino al “mercato dei like”), e un generale “pensiero positivo” comunitario (attraverso le interconnessioni tra giocatori che si aiutano a vicenda). Non tutti i contenuti sono sono condivisibili, ma Hideo Kojima, il designer del gioco, esprime di fatto un pensiero filosofico, il che è molto raro nei videogiochi.
Un gioco come Red Dead Redemption ci ha fatto cogliere la profondità e le possibilità dell’open world, un mondo virtuale aperto e sconfinato, da attraversare liberamente nel suo splendore visivo, e con una giocabilità e interattività quasi totali.
Con The Last of Us 2 ci siamo immerse e immersi nella violenza disperata della post-apocalisse con personaggi queer perfettamente inseriti nel contesto, fuori da stereotipi o norme di genere proprie del “nostro mondo”.
Questo articolo è stato pubblicato sul n. 49 della rivista “Hamelin”, Videogiochi. Un altro modo di raccontare.