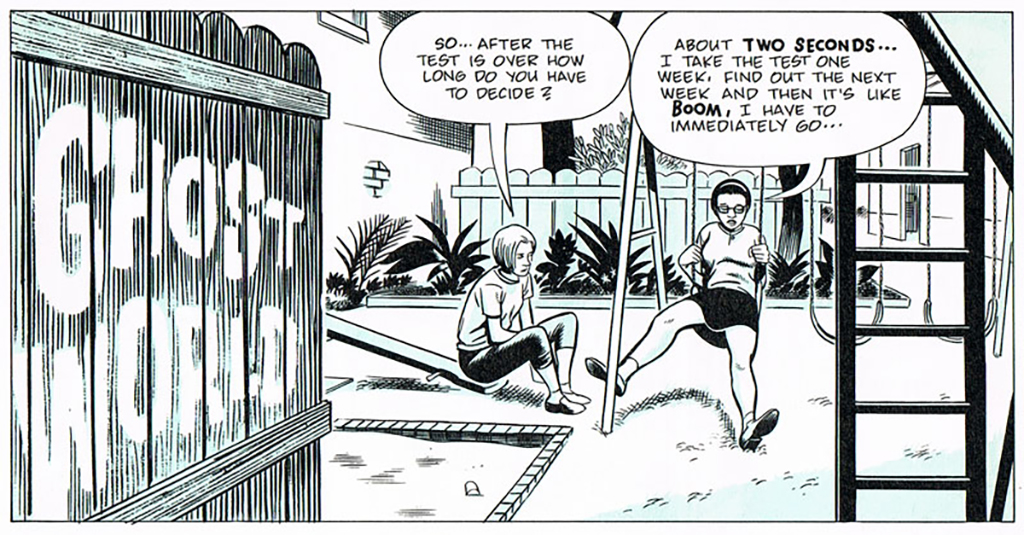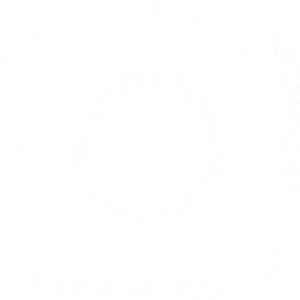di Emilio Varrà

Con Besprizornye. Bambini randagi della Russia sovietica (1917-1935) (Adelphi, 2019) Luciano Mecacci ci offre l’occasione di una lettura importante e solo apparentemente specialistica. Forte di una serietà e piena fondatezza nella documentazione e nell’analisi ma anche di una scrittura vivace e in qualche modo “corale” per la quantità di citazioni e di voci che accoglie, il saggio riesce nella doppia finalità di essere pienamente focalizzato sul proprio oggetto di ricerca e, nello stesso tempo, di aprire a numerosi prolungamenti, digressioni, riflessioni.
—
Quello dei besprizornye è stato un fenomeno impressionante per numeri, impatto sociale e anche penetrazione nell’immaginario: “nella prima metà degli anni Venti i besprizornye erano centinaia di migliaia, con un picco di circa sette milioni nel 1922 (nel 1926 la popolazione dell’URSS era di poco superiore ai 147 milioni di abitanti)”. Per oltre un decennio nella sua forma più intensa, ma protraendosi ben oltre, migliaia e migliaia di bambini e bambine, orfani o abbandonati dalle famiglie, si muovevano quotidianamente nelle città, sui treni, per le strade alla ricerca di cibo, un riparo, un modo qualsiasi per sopravvivere. Una presenza che si fa quasi paesaggio tale è la sua permanenza, ma che diventa protagonista anche nell’immaginario sia come urgenza sociale da risolvere per il neonato stato sovietico, sia come icona in canzoni, fotografie, dipinti, romanzi, film. E Mecacci oscilla con sapienza e un perfetto equilibrio tra i documenti storici e le finzioni nel tentativo, riuscitissimo, di fare un ritratto antropologico di questa infanzia, delle loro condizioni, delle politiche attuate nei loro confronti, ma anche soprattutto dei comportamenti e di un modo di vivere di una società dentro la società, che si barcamena tra nomadismo e nascondimento, tra elemosina e furto, tra interventi educativi e rifiuti e che si impone sull’immagine di un Paese e nella coscienza dell’immaginario occidentale.
Nella sua forma più grave il fenomeno dura un decennio ma perdurerà fino agli anni ’40, nonostante il tentativo di Stalin di rimuovere la questione come risolta agli occhi dei connazionali e all’estero attraverso un’opera di epurazione nella società e nel campo dell’informazione: l’internamento di tanti giovanissimi nei gulag, la censura imposta a ogni voce che tentava di riportare all’attenzione su una realtà comunque ancora drammatica, l’eliminazione di scrittori ed educatori che dieci anni prima erano invece protagonisti.
A leggere la sequenza di eventi che provocarono una tale massa di bambini e bambine randagi si ha l’impressione di una condanna implacabile nella successione della Prima Guerra Mondiale, della Rivoluzione e della guerra civile, della carestia dei primi anni Venti e di quella tremenda di un decennio dopo, delle repressioni staliniane e della Seconda Guerra Mondiale.
Il saggio diventa così occasione per una riflessione più generale sul rapporto tra infanzia e storia e sul modo con cui costruiamo idee d’infanzia nella successione delle epoche storiche. Il bambino si pone come vittima per eccellenza dei mutamenti e delle tragedie della storia, costretto a una condizione passiva di fronte ad accadimenti di cui non ha alcuna responsabilità e condannato a un mutismo e una invisibilità che raramente, e questo è un caso, riescono a essere incrinati.
Eppure sembra avere la capacità talvolta di ottenere una rivincita: non si tratta certo del potere di condizionare il corso degli eventi, piuttosto di porsi come icona capace di incarnare su di sé un intero periodo, di diventarne allo stesso tempo paradigma e metafora. L’infanzia ogni tanto fa capolino nel procedere della storia, sempre da una posizione laterale, come per caso, e magari con il sorriso un po’ sfrontato e un po’ ottuso che sfoggia un bresprizornyj in una celebre foto, riprodotta e analizzata da Mecacci, a fianco di Lenin, durante la festa del Primo maggio del 1919 alla Piazza Rossa di Mosca. Sono apparizioni fugaci, momentanee e isolate, che pure hanno la forza di fissare un periodo, di farsene simbolo e di produrre simboli: le tante foto di bambini viaggiatori clandestini sopra o sotto i treni o dentro i calderoni d’asfalto alla caccia di un poco di tepore o in bella fila attorno alla mensa di un orfanatrofio creano una sorta di “punteggiatura” della storia, ma come i sassolini di Pollicino riescono a fornire un disegno, un ritratto significativo e, quel che più conta, indelebile. Basti pensare, per fare un esempio diverso, alla bambina che corre nuda sotto i bombardamenti di napalm nella Guerra del Vietnam, capace di farsi sintesi visiva e di memoria senza concorrenza nel nostro immaginario.
Due interrogativi emergono allora: l’infanzia è destinata a “comparire nella storia” solo quando si presenta nella sua forma più tragica? È quella della “vittima innocente” la sua unica possibilità di apparizione? La sofferenza in cambio della visibilità? Una sofferenza che deve essere evidente ed estrema, quasi a riportare la natura bambina a quella di freak, di mostro per cui trovare compassione e repulsione insieme. Se non c’è questa spettacolarizzazione della sofferenza, per quanto subita e certo non perseguita, i più piccoli sono destinati a rimanere oltre i margini delle fotografie e delle notizie?
Vengono in mente in realtà anche immagini diverse, bambini e bambine come sintomo (o propaganda) di speranza, quasi a recuperare una visione messianica e di salvazione che pure attribuiamo inconsciamente all’infanzia.
Nel suo fondamentale Il bambino estraneo Dieter Richter mostra come essa non sia comparsa all’immaginazione adulta solo in epoca borghese, ma che fosse già presente in alcune forme specifiche e prevalentemente religiose: il bambino santo o miracolato oppure il bambino demone e maligno. Un atteggiamento nettamente divaricato tra minaccia o devozione ma in realtà omogeneo nel considerare comunque l’infanzia come essere sovrumano o subumano, creatura celeste o ctonia, comunque non “di questo mondo”, non da guardare sullo stesso nostro piano. Può sembrare molto lontana questa ottica, eppure credo invece che sia sempre da tenere presente perché tuttora è fondativa di gran parte dei modi e dei motivi per cui noi guardiamo ai bambini e ce li raccontiamo: non abiteranno più paradisi o inferni, ma tuttora dobbiamo “cacciarli” fuori di noi per poterli vedere, trasformarli in “immagini d’infanzia” piuttosto che in bambini veri. La loro condizione durante la pandemia mi sembra piuttosto eloquente, non c’è “abbastanza da vedere” in bambini e bambine costretti a rimanere per mesi chiusi in casa, senza poter ambire a una passeggiata o a un gioco in cortile.
L’altro interrogativo riguarda il modo (l’unico?) con cui sembra che noi adulti siamo capaci di prendere in considerazione l’infanzia, ovvero trasformandola (riducendola?) in icona, in immagine. Novella Alice, l’infanzia sembra poter ambire al privilegio del nostro sguardo e della nostra attenzione unicamente quando attraversa lo specchio della rappresentazione, e di conseguenza anche della finzione nel senso più ampio del termine. Non si tratta solo di una colpevole trascuratezza, del segno di un disinteresse che pure è ben evidente, ma del modo con cui noi siamo capaci di relazionarci alla presenza bambina. Sembra che l’immaginario sia lo strumento privilegiato che abbiamo elaborato per poter davvero lanciare un ponte verso un’età di cui troppo spesso dimentichiamo l’alterità (e facciamo di tutto per eliminarla il prima possibile).
Quello del rifugio nell’immaginario è una “trappola” che continuamente insidia la lettura di Besprizornye: anche di fronte alla sequenza dei fatti o alla lettura di dati ufficiali immeditatamente diamo vita a una costellazione di altri riferimenti, che insieme vanno a costituire l’idea di infanzia che ognuno ha come individuo e come collettività. Gli stracci e la sporcizia, l’estrema povertà, la strada come spazio di azione, lo sfruttamento da parte di adulti senza scrupoli, l’universo misero e spesso violento degli orfanatrofi e poi dei gulag subito ci riportano a personaggi dickensiani, a un altro tempo in cui l’urgenza drammatica della realtà si è fusa endemicamente con le finzioni e le rappresentazioni. E che dire dei bimbi strilloni o venditori ambulanti nei mercati o piccoli hobo d’oriente sui treni che fanno da contraltare a quelli delle metropoli o della Depressione americana? E, quando si legge di besprizornye specializzati nel fare da guida ai bordelli o ai locali malfamati delle città, come non pensare a Kim, “l’amico di tutti”, che si muove con uguale naturalezza per le strade di Lahore?
D’altra parte questo travalicamento dalla realtà all’immaginario è un processo ben raccontato da Mecacci nello stesso Impero sovietico e nei medesimi anni dell’emergenza storica: le masse e i corpi di bambini e bambine con estrema facilità attraversano il confine del racconto, rendendo labile la soglia tra documento e narrazione: un’inchiesta diventa presto un romanzo di formazione, una denuncia si fa repertorio di canzoni, le fotografie pian piano disegnano alcuni canoni visivi, con i treni, i calderoni d’asfalto, i corpi addormentati uno sull’altro per darsi calore, il besprizornyj diventa pienamente un personaggio, con i suoi topoi narrativi (ad esempio l’accompagnatore di ciechi), novello eroe della letteratura per l’infanzia sovietica. Già allora si alzarono voci che mettevano in guardia sui pericoli di questo slittamento che rischiava di trasformare un grave problema sociale in una finzione idealizzata. Tra queste la più illustre è certo quella di Makarenko, autore lui stesso del Poema pedagogico: “Chissà perché nella nostra letteratura e fra i nostri intellettuali la figura del ragazzo abbandonato viene sempre presentata come quella di un eroe byroniano.”
Mecacci chiude il suo saggio con un’ultima frase significativa: “Anche i figli del cuculo, i figli di nessuno, non sono stati una metafora.” E fa bene a ricordarlo perché il processo di metaforizzazione dell’infanzia può facilmente diventare una forma nobile, e meno sconveniente, di rimozione, un modo per accomodare nelle nostre coscienze la scomodità della presenza bambina nel reale. Allo stesso modo però diventa uno strumento per fare i conti con questa scomodità, perché di scomodità sempre e comunque si tratta, una maniera di guardarla di traverso, se non in faccia. Ed è una griglia interpretativa che ha una sua ineludibilità, tanto che viene da guardare con sospetto chi dichiara il contrario.
Ecco allora che quando leggiamo dei besprizornye che si accalcavano nei sotterranei delle stazioni, infilandosi in cunicoli stretti in cui era difficile prenderli o nei pertugi più remoti, non importa più se è un articolo della “Pravda” o un racconto, perché immediatamente questi bambini si trasformano nella nostra immaginazione. Da una parte riattiva il binomio bambino-animale e li muta in topi (creature piccole, numerose, nobili, indifese, ma anche minacciose, sporche, portatrici di peste), dall’altra avverte un’eco dei tanti pollicini della fiaba che vivono o attraversano la sotterraneità, tengono saldo il legame archetipico tra bambini e morti, si trasformano nel “piccolo popolo” delle leggende. O ancora quando si legge delle lamentele degli adulti prigionieri nei gulag perché non sopportano le spinte, le lotte, i lazzi dei ragazzini prigionieri come loro ma ancora capaci di correre dopo una giornata di lavori forzati, non si può non pensare alla dynamis del puer, al volo zigzagante di Peter Pan o ai balzi di Pinocchio, e tutti – bambini veri e finti – sembrano fedeli adepti di Mercurio e di tutta la genia di bricconi divini a cui appartiene. Mito, fiaba, storia, società non sono la stessa cosa ma sono sempre correlati e la presenza bambina ci costringe a ricordarlo con maggiore evidenza di altri.
Un’ultima riflessione, sempre scaturita dalla lettura del saggio: i bambini non sono solo “altro da noi”, ma sono anche “contro di noi”: la loro alterità, l’alternativa che incarnano con il loro semplice essere inevitabilmente ci dà fastidio, diventa oggetto di una conflittualità più o meno esplicitata. Mai come oggi essa è – per noi ricchi occidentali – nascosta e rimossa, coperta da strati e strati di politicamente corretto, di buonismo, di iperprotezionsimo (e questo mina alla base la possibilità di un dialogo autentico), ma non per questo non esiste perché alla fine si tratta di un bivio radicale: “o noi o loro” (ed è più probabile che a vincerla, per le leggi del tempo, siano loro…). La realtà drammatica che ha visto nascere il fenomeno dei brespizornye ha avuto “il merito” di ricordarcelo: sono tanti i casi singoli che cita Mecacci di scontri, sfruttamenti, vendette, violenze, ma quello che più conta è la massa: un bambino, due, tre, fanno tenerezza, cinquanta fanno paura. Quello che film e storie di fantascienza o di orrore hanno tante volte raccontato, bambini alieni, mutanti o demoniaci che si rivelano minaccia per l’intera comunità, qui è realtà storica, determina ad esempio il comportamento dei controllori dei treni che preferivano chiudere un occhio per non avere problemi, condiziona gli spostamenti notturni degli adulti che cercano di non trovarsi da soli in strada in balia di un gruppo di ragazzini. Non è solo il numero a incutere timore, è la compattezza di questo “popolo alternativo”, quasi un corpo solo (e in questo senso gli ammassi di corpi addormentati acquisisce anche un altro valore) e una lingua a parte. E anche una mobilità incontenibile che si traduceva in vere e proprie migrazioni stagionali, in viaggi clandestini, in fughe da colonie e orfanatrofi, espressione di una lotta per la sopravvivenza in primis, ma anche di un anelito insopprimibile verso il movimento e la libertà, di una propensione naturalmente anarchica in un qualche modo. Insomma, i bambini ci stanno a guardare, è vero, ma spesso è perché non si lascia fare loro altro.
Per approfondire: una bella intervista di Rodolfo Sacchettini a Luciano Mecacci è stata pubblicata sul n. 72 della rivista “Gli asini”, a febbraio 2020.
Besprizornye: infanzia tra storia e racconto
di Emilio Varrà

Con Besprizornye. Bambini randagi della Russia sovietica (1917-1935) (Adelphi, 2019) Luciano Mecacci ci offre l’occasione di una lettura importante e solo apparentemente specialistica. Forte di una serietà e piena fondatezza nella documentazione e nell’analisi ma anche di una scrittura vivace e in qualche modo “corale” per la quantità di citazioni e di voci che accoglie, il saggio riesce nella doppia finalità di essere pienamente focalizzato sul proprio oggetto di ricerca e, nello stesso tempo, di aprire a numerosi prolungamenti, digressioni, riflessioni.
—
Quello dei besprizornye è stato un fenomeno impressionante per numeri, impatto sociale e anche penetrazione nell’immaginario: “nella prima metà degli anni Venti i besprizornye erano centinaia di migliaia, con un picco di circa sette milioni nel 1922 (nel 1926 la popolazione dell’URSS era di poco superiore ai 147 milioni di abitanti)”. Per oltre un decennio nella sua forma più intensa, ma protraendosi ben oltre, migliaia e migliaia di bambini e bambine, orfani o abbandonati dalle famiglie, si muovevano quotidianamente nelle città, sui treni, per le strade alla ricerca di cibo, un riparo, un modo qualsiasi per sopravvivere. Una presenza che si fa quasi paesaggio tale è la sua permanenza, ma che diventa protagonista anche nell’immaginario sia come urgenza sociale da risolvere per il neonato stato sovietico, sia come icona in canzoni, fotografie, dipinti, romanzi, film. E Mecacci oscilla con sapienza e un perfetto equilibrio tra i documenti storici e le finzioni nel tentativo, riuscitissimo, di fare un ritratto antropologico di questa infanzia, delle loro condizioni, delle politiche attuate nei loro confronti, ma anche soprattutto dei comportamenti e di un modo di vivere di una società dentro la società, che si barcamena tra nomadismo e nascondimento, tra elemosina e furto, tra interventi educativi e rifiuti e che si impone sull’immagine di un Paese e nella coscienza dell’immaginario occidentale.
Nella sua forma più grave il fenomeno dura un decennio ma perdurerà fino agli anni ’40, nonostante il tentativo di Stalin di rimuovere la questione come risolta agli occhi dei connazionali e all’estero attraverso un’opera di epurazione nella società e nel campo dell’informazione: l’internamento di tanti giovanissimi nei gulag, la censura imposta a ogni voce che tentava di riportare all’attenzione su una realtà comunque ancora drammatica, l’eliminazione di scrittori ed educatori che dieci anni prima erano invece protagonisti.
A leggere la sequenza di eventi che provocarono una tale massa di bambini e bambine randagi si ha l’impressione di una condanna implacabile nella successione della Prima Guerra Mondiale, della Rivoluzione e della guerra civile, della carestia dei primi anni Venti e di quella tremenda di un decennio dopo, delle repressioni staliniane e della Seconda Guerra Mondiale.
Il saggio diventa così occasione per una riflessione più generale sul rapporto tra infanzia e storia e sul modo con cui costruiamo idee d’infanzia nella successione delle epoche storiche. Il bambino si pone come vittima per eccellenza dei mutamenti e delle tragedie della storia, costretto a una condizione passiva di fronte ad accadimenti di cui non ha alcuna responsabilità e condannato a un mutismo e una invisibilità che raramente, e questo è un caso, riescono a essere incrinati.
Eppure sembra avere la capacità talvolta di ottenere una rivincita: non si tratta certo del potere di condizionare il corso degli eventi, piuttosto di porsi come icona capace di incarnare su di sé un intero periodo, di diventarne allo stesso tempo paradigma e metafora. L’infanzia ogni tanto fa capolino nel procedere della storia, sempre da una posizione laterale, come per caso, e magari con il sorriso un po’ sfrontato e un po’ ottuso che sfoggia un bresprizornyj in una celebre foto, riprodotta e analizzata da Mecacci, a fianco di Lenin, durante la festa del Primo maggio del 1919 alla Piazza Rossa di Mosca. Sono apparizioni fugaci, momentanee e isolate, che pure hanno la forza di fissare un periodo, di farsene simbolo e di produrre simboli: le tante foto di bambini viaggiatori clandestini sopra o sotto i treni o dentro i calderoni d’asfalto alla caccia di un poco di tepore o in bella fila attorno alla mensa di un orfanatrofio creano una sorta di “punteggiatura” della storia, ma come i sassolini di Pollicino riescono a fornire un disegno, un ritratto significativo e, quel che più conta, indelebile. Basti pensare, per fare un esempio diverso, alla bambina che corre nuda sotto i bombardamenti di napalm nella Guerra del Vietnam, capace di farsi sintesi visiva e di memoria senza concorrenza nel nostro immaginario.
Due interrogativi emergono allora: l’infanzia è destinata a “comparire nella storia” solo quando si presenta nella sua forma più tragica? È quella della “vittima innocente” la sua unica possibilità di apparizione? La sofferenza in cambio della visibilità? Una sofferenza che deve essere evidente ed estrema, quasi a riportare la natura bambina a quella di freak, di mostro per cui trovare compassione e repulsione insieme. Se non c’è questa spettacolarizzazione della sofferenza, per quanto subita e certo non perseguita, i più piccoli sono destinati a rimanere oltre i margini delle fotografie e delle notizie?
Vengono in mente in realtà anche immagini diverse, bambini e bambine come sintomo (o propaganda) di speranza, quasi a recuperare una visione messianica e di salvazione che pure attribuiamo inconsciamente all’infanzia.
Nel suo fondamentale Il bambino estraneo Dieter Richter mostra come essa non sia comparsa all’immaginazione adulta solo in epoca borghese, ma che fosse già presente in alcune forme specifiche e prevalentemente religiose: il bambino santo o miracolato oppure il bambino demone e maligno. Un atteggiamento nettamente divaricato tra minaccia o devozione ma in realtà omogeneo nel considerare comunque l’infanzia come essere sovrumano o subumano, creatura celeste o ctonia, comunque non “di questo mondo”, non da guardare sullo stesso nostro piano. Può sembrare molto lontana questa ottica, eppure credo invece che sia sempre da tenere presente perché tuttora è fondativa di gran parte dei modi e dei motivi per cui noi guardiamo ai bambini e ce li raccontiamo: non abiteranno più paradisi o inferni, ma tuttora dobbiamo “cacciarli” fuori di noi per poterli vedere, trasformarli in “immagini d’infanzia” piuttosto che in bambini veri. La loro condizione durante la pandemia mi sembra piuttosto eloquente, non c’è “abbastanza da vedere” in bambini e bambine costretti a rimanere per mesi chiusi in casa, senza poter ambire a una passeggiata o a un gioco in cortile.
L’altro interrogativo riguarda il modo (l’unico?) con cui sembra che noi adulti siamo capaci di prendere in considerazione l’infanzia, ovvero trasformandola (riducendola?) in icona, in immagine. Novella Alice, l’infanzia sembra poter ambire al privilegio del nostro sguardo e della nostra attenzione unicamente quando attraversa lo specchio della rappresentazione, e di conseguenza anche della finzione nel senso più ampio del termine. Non si tratta solo di una colpevole trascuratezza, del segno di un disinteresse che pure è ben evidente, ma del modo con cui noi siamo capaci di relazionarci alla presenza bambina. Sembra che l’immaginario sia lo strumento privilegiato che abbiamo elaborato per poter davvero lanciare un ponte verso un’età di cui troppo spesso dimentichiamo l’alterità (e facciamo di tutto per eliminarla il prima possibile).
Quello del rifugio nell’immaginario è una “trappola” che continuamente insidia la lettura di Besprizornye: anche di fronte alla sequenza dei fatti o alla lettura di dati ufficiali immeditatamente diamo vita a una costellazione di altri riferimenti, che insieme vanno a costituire l’idea di infanzia che ognuno ha come individuo e come collettività. Gli stracci e la sporcizia, l’estrema povertà, la strada come spazio di azione, lo sfruttamento da parte di adulti senza scrupoli, l’universo misero e spesso violento degli orfanatrofi e poi dei gulag subito ci riportano a personaggi dickensiani, a un altro tempo in cui l’urgenza drammatica della realtà si è fusa endemicamente con le finzioni e le rappresentazioni. E che dire dei bimbi strilloni o venditori ambulanti nei mercati o piccoli hobo d’oriente sui treni che fanno da contraltare a quelli delle metropoli o della Depressione americana? E, quando si legge di besprizornye specializzati nel fare da guida ai bordelli o ai locali malfamati delle città, come non pensare a Kim, “l’amico di tutti”, che si muove con uguale naturalezza per le strade di Lahore?
D’altra parte questo travalicamento dalla realtà all’immaginario è un processo ben raccontato da Mecacci nello stesso Impero sovietico e nei medesimi anni dell’emergenza storica: le masse e i corpi di bambini e bambine con estrema facilità attraversano il confine del racconto, rendendo labile la soglia tra documento e narrazione: un’inchiesta diventa presto un romanzo di formazione, una denuncia si fa repertorio di canzoni, le fotografie pian piano disegnano alcuni canoni visivi, con i treni, i calderoni d’asfalto, i corpi addormentati uno sull’altro per darsi calore, il besprizornyj diventa pienamente un personaggio, con i suoi topoi narrativi (ad esempio l’accompagnatore di ciechi), novello eroe della letteratura per l’infanzia sovietica. Già allora si alzarono voci che mettevano in guardia sui pericoli di questo slittamento che rischiava di trasformare un grave problema sociale in una finzione idealizzata. Tra queste la più illustre è certo quella di Makarenko, autore lui stesso del Poema pedagogico: “Chissà perché nella nostra letteratura e fra i nostri intellettuali la figura del ragazzo abbandonato viene sempre presentata come quella di un eroe byroniano.”
Mecacci chiude il suo saggio con un’ultima frase significativa: “Anche i figli del cuculo, i figli di nessuno, non sono stati una metafora.” E fa bene a ricordarlo perché il processo di metaforizzazione dell’infanzia può facilmente diventare una forma nobile, e meno sconveniente, di rimozione, un modo per accomodare nelle nostre coscienze la scomodità della presenza bambina nel reale. Allo stesso modo però diventa uno strumento per fare i conti con questa scomodità, perché di scomodità sempre e comunque si tratta, una maniera di guardarla di traverso, se non in faccia. Ed è una griglia interpretativa che ha una sua ineludibilità, tanto che viene da guardare con sospetto chi dichiara il contrario.
Ecco allora che quando leggiamo dei besprizornye che si accalcavano nei sotterranei delle stazioni, infilandosi in cunicoli stretti in cui era difficile prenderli o nei pertugi più remoti, non importa più se è un articolo della “Pravda” o un racconto, perché immediatamente questi bambini si trasformano nella nostra immaginazione. Da una parte riattiva il binomio bambino-animale e li muta in topi (creature piccole, numerose, nobili, indifese, ma anche minacciose, sporche, portatrici di peste), dall’altra avverte un’eco dei tanti pollicini della fiaba che vivono o attraversano la sotterraneità, tengono saldo il legame archetipico tra bambini e morti, si trasformano nel “piccolo popolo” delle leggende. O ancora quando si legge delle lamentele degli adulti prigionieri nei gulag perché non sopportano le spinte, le lotte, i lazzi dei ragazzini prigionieri come loro ma ancora capaci di correre dopo una giornata di lavori forzati, non si può non pensare alla dynamis del puer, al volo zigzagante di Peter Pan o ai balzi di Pinocchio, e tutti – bambini veri e finti – sembrano fedeli adepti di Mercurio e di tutta la genia di bricconi divini a cui appartiene. Mito, fiaba, storia, società non sono la stessa cosa ma sono sempre correlati e la presenza bambina ci costringe a ricordarlo con maggiore evidenza di altri.
Un’ultima riflessione, sempre scaturita dalla lettura del saggio: i bambini non sono solo “altro da noi”, ma sono anche “contro di noi”: la loro alterità, l’alternativa che incarnano con il loro semplice essere inevitabilmente ci dà fastidio, diventa oggetto di una conflittualità più o meno esplicitata. Mai come oggi essa è – per noi ricchi occidentali – nascosta e rimossa, coperta da strati e strati di politicamente corretto, di buonismo, di iperprotezionsimo (e questo mina alla base la possibilità di un dialogo autentico), ma non per questo non esiste perché alla fine si tratta di un bivio radicale: “o noi o loro” (ed è più probabile che a vincerla, per le leggi del tempo, siano loro…). La realtà drammatica che ha visto nascere il fenomeno dei brespizornye ha avuto “il merito” di ricordarcelo: sono tanti i casi singoli che cita Mecacci di scontri, sfruttamenti, vendette, violenze, ma quello che più conta è la massa: un bambino, due, tre, fanno tenerezza, cinquanta fanno paura. Quello che film e storie di fantascienza o di orrore hanno tante volte raccontato, bambini alieni, mutanti o demoniaci che si rivelano minaccia per l’intera comunità, qui è realtà storica, determina ad esempio il comportamento dei controllori dei treni che preferivano chiudere un occhio per non avere problemi, condiziona gli spostamenti notturni degli adulti che cercano di non trovarsi da soli in strada in balia di un gruppo di ragazzini. Non è solo il numero a incutere timore, è la compattezza di questo “popolo alternativo”, quasi un corpo solo (e in questo senso gli ammassi di corpi addormentati acquisisce anche un altro valore) e una lingua a parte. E anche una mobilità incontenibile che si traduceva in vere e proprie migrazioni stagionali, in viaggi clandestini, in fughe da colonie e orfanatrofi, espressione di una lotta per la sopravvivenza in primis, ma anche di un anelito insopprimibile verso il movimento e la libertà, di una propensione naturalmente anarchica in un qualche modo. Insomma, i bambini ci stanno a guardare, è vero, ma spesso è perché non si lascia fare loro altro.
Per approfondire: una bella intervista di Rodolfo Sacchettini a Luciano Mecacci è stata pubblicata sul n. 72 della rivista “Gli asini”, a febbraio 2020.