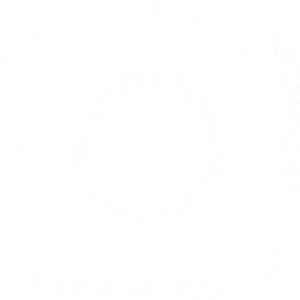di Giordana Piccinini ed Emilio Varrà

“Ciao, Wendy’ disse Peter. ‘Te ne vai?’
“Sì”.
‘Non credi, Peter” disse lei titubante, “di avere qualcosa da dire ai miei genitori? Qualcosa che riguarda un argomento molto delicato?’”
“No”.
“Qualcosa che riguarda me, Peter?”
La signora Darling si avvicinò alla finestra, perché adesso teneva d’occhio Wendy con molta attenzione. Disse a Peter che aveva adottato gli altri ragazzi, e che le sarebbe piaciuto adottare anche lui.
“Mi manderete a scuola?” chiede Peter con diffidenza.
“Sì”.
“E poi in ufficio?”
“Penso di sì”.
“E presto diventerò un uomo?”
“Molto presto”.
“Non voglio andare a scuola a imparare delle cose noiose’” disse Peter agitato. “Non voglio diventare un uomo. Pensi signora mamma di Wendy, se un giorno mi dovessi svegliare con la barba”.
—
È lunga l’ombra di Peter Pan. Non solo tende ad andare per conto suo, incidente o esca che sia, ma continua a ribadire la sua presenza: dalla sua apparizione all’inizio del ‘900 ha continuato a ricomparire, nelle case borghesi di Londra come nelle villette a schiera di Spinaceto.
Favolacce dei fratelli D’Innocenzo cova da prima del loro esordio, La terra dell’abbastanza, e nasce da un sentimento preciso, a sentire le loro parole: la rabbia. Un sentimento che dilagava anche agli albori del secolo ventesimo, o “secolo dei fanciulli” per citare il titolo di un saggio allora famoso a firma di Ellen Key: l’infanzia, la dynamis del puer, si faceva sentire in tutto il suo vigore attraverso i monelli dei fumetti, gli studi di Freud, le sperimentazioni delle avanguardie storiche, senza dimenticare le ambiguità e le derive politiche e, ovviamente, Peter Pan.
Una soluzione la si trovò: ne “L’Unità” del 22 agosto del 1997 si poteva leggere un articolo di Michele Sartori dal titolo Peter Pan l’eterno bambino è morto soldato sul Grappa. Così iniziava: “‘Nessuno mi prenderà per farmi diventare un uomo!… Poi volò via… Fu questa l’ultima volta che Wendy, la piccola Wendy, vide Peter’. E poi? Poi Peter Pan finì ammazzato da un colpo di moschetto italiano, o da una bomba a mano ‘Ballerina’: sul monte Grappa, alla fine della prima guerra mondiale. Non ci credete? In cima al Grappa. Nell’ossario monumentale che raccoglie i resti delle decine di migliaia di soldati italiani, tedeschi, austriaci, ungheresi, bosniaci morti tra quei monti, c’è un loculo misterioso, nel settore ungarico: “Soldato Peter Pan”, è inciso nel bronzo. (…) La Croce Nera austriaca, che conserva a Vienna tutti i dati dei caduti austroungarici, su Peter Pan ha una cartelletta quasi vuota: ‘Peter Pan, nato nel 1897 a Riszkabanya-Krassoszöreny, Ungheria. 30° reggimento di fanteria Honved, 7 compagnia. Morto in azione il 19.9.1918 a Col Caprile, quota 1.331”.

Qui sta la differenza sostanziale: se furono tanti i ragazzi ancora senza barba che morirono nella Grande Guerra, mandati al massacro da una generazione di adulti, in Favolacce la situazione si ribalta: sono i bambini e le bambine, silenti e consapevoli, a decidere di sparire. Ma è proprio la radice di questo gesto a farci tornare al primo volo di Peter Pan, che dietro la maschera di avventure e capriole nell’aria, nasconde il “gran rifiuto”, l’unico davvero possibile.
Meglio l’Isola-che-non-c’è, un’isola dei morti travestita da parco dei divertimenti. L’alternativa è descritta dallo stesso Barrie, impietosa pur dietro l’affabilità del tono: “Anche gli altri ragazzi erano cresciuti, ma non vale la pena parlare troppo a lungo di loro. Potete vedere i gemelli, Pennino e Ricciolo recarsi tutti i giorni all’ufficio con l’ombrello e una cartella di cuoio sotto il braccio. Michele fa il macchinista. Piumetto ha sposato una nobile fanciulla ed è diventato lord. Vedete quel giudice in parrucca che esce da una porta di ferro? Quel giudice era una volta Zufolo. Quel signore con la barba, che non sa raccontare ai suoi bambini nemmeno una favola, è Gianni”.
C’è una linea evidente di continuità tra il catalogo di questi destini e i personaggi adulti del film dei D’Innocenzo. L’unica differenza è data dal fatto che se ai tempi di Barrie l’aspirazione e la classe borghese aveva ancora una sua solidità, ora mostra tutte le sue crepe, non è più sostenibile, non c’è sacrificio che può giustificarne il prezzo. Lo sguardo dei due registi in questo si fa lucido, spietato, chirurgico, e sta tutto nello squallore di villette a schiera che ammiccano a una raggiunta posizione, a fabbrichette di sapone che non rovinano la pelle a quegli stessi bambini ai quali non si sa neppure rivolgere la parola, a salotti con moquette e tappeto come a volerle doppiamente nascondere quelle crepe, a barbecue dove la carne va di traverso e il boccone che non si riesce a sputare è quello di un’esistenza, a piscine esibite al vicinato e squartate poi in un disvelamento notturno. Non è un caso che l’unico ragazzino che si salva sia il figlio del personaggio che sembra meno interessato a farsi e a mostrare una posizione, ha ancora radici popolari, punta semplicemente alla sopravvivenza. Figura grottesca, certo non invidiabile per l’orizzonte limitato che incarna, pure ha conservato una sua insopprimibile vitalità, il suo corpo si muove scomposto e quasi comico, irrefrenabile sullo schermo, come la sua lingua che si traduce in un instancabile soliloquio che continuamente sollecita il figlio, non si cura dell’assenza di risposte, si aggrappa ai fragili sorrisi che ogni tanto riceve.
L’altro corpo veramente presente nel film, (mostrato per pezzi che via via la macchina da presa ci mostra a definirne i contorni) anch’esso ingombrante e impresentabile agli occhi piccolo borghesi della comunità, è quello della ragazza madre, esistenza alla deriva, eppure l’unica che in qualche modo, tra contrattazioni economiche, grottesche profferte sessuali, insulti e volgarità instaura un dialogo con uno dei piccoli ed è interpellata da lui, forse perché ne sente comunque una vicinanza, riconosce una medesima incapacità ad adattarsi, e lo stesso coraggio a fare il grande salto.
Per il resto è silenzio. Il silenzio è un bisturi micidiale con cui il film incide l‘esperienza dello spettatore. Un silenzio vicendevole, che al di là delle eccezioni indicate, vive nei due sensi, a segnare una distanza abissale, quella stessa che separa Londra dall’Isola-che-non-c’è: gli adulti neppure concepiscono di poter davvero instaurare un dialogo con i figli, sono incapaci di chiedere una spiegazione anche quando trovano le bombe autofabbricate nelle camerette, al massimo li prendono a calci. Il mutismo dei ragazzini e delle ragazzine, sottolineato dalla forza dei primi piani e dal sapiente uso della voce fuori campo, è già il segno di una scelta, di un rifiuto radicale ai modelli che si trovano davanti, e che non danno mai il segno di un’alternativa, di una via d’uscita. D’altronde sanno bene che le loro voci non potrebbero essere ascoltate. Si limitano così a recitare a soggetto, leggendo pagelle dai voti ineccepibili o scartando regali e ringraziamenti a un compleanno, prontamente ripresi per immortalare il momento, e poi lasciare di nuovo spazio al volgare parlottio dei grandi, vuoto e ingombrante allo stesso tempo.
Questo silenzio distanzia Favolacce da Peter Pan, nella tonalità più che nella sostanza. Il romanzo di Barrie ha la capacità di mascherare la sua natura mortifera con la vivacità del gioco e dell’avventura, di una affabulazione che ha ancora la vitalità della fiaba e del racconto, il film invece sembra vicino a romanzi come Un gioco da bambini di Ballard o L‘ultima ora di Dufossé. E non importa che in un caso siano i più giovani a uccidere con fredda sistematicità i genitori e nell’altro sia una classe di una scuola media francese a progettare un suicidio collettivo di fronte a un insegnante non stupido né insensibile, ma incapace comunque di trovare un qualche canale di comunicazione: entrambi sono ritratti impietosi di uno stato di afasia cronica tra generazioni. Ed essa inquina anche la relazione tra coetanei, ancora tenera quando si mescola all’impaccio dei primi innamoramenti, tristemente grottesca quando si traveste già del vocabolario adulto.

Infine c’è il tempo, quello che in Peter Pan si ferma e che qui invece sembra annunciarsi: siamo nell’estate alla fine della prima media, siamo all’estate con la “E” maiuscola, quella del passaggio, della pubertà. “Chissà se mi innamorerò anche quest’estate” recita la voce fuori campo mentre legge il diario ritrovato di una delle ragazzine morte. Sembra il segno di un’apertura, di un desiderio che contempla ancora una curiosità e un futuro. Esso trova anche un momento di incarnazione, quando il film si sofferma su una battaglia con i gavettoni e i corpi, la giovinezza, le risate, il rincorrersi occupano lo schermo e lo sguardo dello spettatore, con una pienezza senza ombre, se non fosse che un rallenty (simile in questo a quello di un altro film sulla pubertà: Picnic ad Hanging Rock di Peter Weir) fa venire il sospetto di un’eternizzazione, di un’ultima immagine prima della scomparsa. Ma questo tempo proiettato in avanti, esplorativo, ben presto si trasforma nell‘orizzonte di un’esperienza chiusa: “facciamo sesso anche noi, così abbiamo fatto tutto” dice una ragazzina all’amico. Lo stesso che confesserà in un momento di debolezza, o in uno strenuo tentativo di lanciare un ponte verso i più grandi, di aver fabbricato una bomba: “così finisce tutto”.
Questo “tutto” così ribadito sembra davvero il segno dell’esaurimento di una possibilità di crescita, di una propensione in avanti, la negazione dell’avventura: “cresceva già morta la ragazzina” sentenzia la voce fuori campo che legge il diario ritrovato. Rimane da capire quando scocca il primo rintocco. Una delle più efficaci lacune del film è quella che tace sul momento della decisione di farla finita. L’innesco concreto è chiaro ed è nell’ultima lezione del professore, altra figura che ancora parla ai ragazzini e ha una autorità e influenza ai loro occhi: accusato e licenziato da scuola per aver (involontariamente?) provocato la costruzione delle bombe chiede di poter fare un’ultima lezione e si trasforma nel Pifferaio di Hamelin, sa che la vendetta più dura contro chi lo ha disprezzato è portarsi via l’infanzia.
Ma c’era ancora? La sua è una reale istigazione o semplicemente lo strumento concreto per portare a termine un piano già meditato? E quanto nel suo gesto c’è della logica adulta della vendetta o della compassione per un destino che già si conosce e nel profondo si condivide?
Viene in mente Pascoli, autore nel 1897 de Il fanciullino, altro manifesto della centralità che avrà l’infanzia nel secolo a venire, ma anche de L’aquilone, canto funebre e riconoscente alla morte bambina:
“Meglio venirci ansante, roseo, molle
di sudor, come dopo una gioconda
corsa di gara per salire un colle!
Meglio venirci con la testa bionda,
che poi che fredda giacque sul guanciale,
ti pettinò co’ bei capelli a onda tua madre…
adagio, per non farti male”.
I ragazzini e le ragazzine di Favolacce sono deprivati anche della possibilità di “venirci ansanti”: a loro è negato anche il diritto dell’ultima corsa.
—
Questo articolo è apparso sul numero 77 della rivista Gli Asini, uscito a luglio 2020. Per abbonarsi alla rivista e sostenere Gli Asini: gliasinirivista.org.
Favolacce: Peter Pan sceglie di non starci
di Giordana Piccinini ed Emilio Varrà

“Ciao, Wendy’ disse Peter. ‘Te ne vai?’
“Sì”.
‘Non credi, Peter” disse lei titubante, “di avere qualcosa da dire ai miei genitori? Qualcosa che riguarda un argomento molto delicato?’”
“No”.
“Qualcosa che riguarda me, Peter?”
La signora Darling si avvicinò alla finestra, perché adesso teneva d’occhio Wendy con molta attenzione. Disse a Peter che aveva adottato gli altri ragazzi, e che le sarebbe piaciuto adottare anche lui.
“Mi manderete a scuola?” chiede Peter con diffidenza.
“Sì”.
“E poi in ufficio?”
“Penso di sì”.
“E presto diventerò un uomo?”
“Molto presto”.
“Non voglio andare a scuola a imparare delle cose noiose’” disse Peter agitato. “Non voglio diventare un uomo. Pensi signora mamma di Wendy, se un giorno mi dovessi svegliare con la barba”.
—
È lunga l’ombra di Peter Pan. Non solo tende ad andare per conto suo, incidente o esca che sia, ma continua a ribadire la sua presenza: dalla sua apparizione all’inizio del ‘900 ha continuato a ricomparire, nelle case borghesi di Londra come nelle villette a schiera di Spinaceto.
Favolacce dei fratelli D’Innocenzo cova da prima del loro esordio, La terra dell’abbastanza, e nasce da un sentimento preciso, a sentire le loro parole: la rabbia. Un sentimento che dilagava anche agli albori del secolo ventesimo, o “secolo dei fanciulli” per citare il titolo di un saggio allora famoso a firma di Ellen Key: l’infanzia, la dynamis del puer, si faceva sentire in tutto il suo vigore attraverso i monelli dei fumetti, gli studi di Freud, le sperimentazioni delle avanguardie storiche, senza dimenticare le ambiguità e le derive politiche e, ovviamente, Peter Pan.
Una soluzione la si trovò: ne “L’Unità” del 22 agosto del 1997 si poteva leggere un articolo di Michele Sartori dal titolo Peter Pan l’eterno bambino è morto soldato sul Grappa. Così iniziava: “‘Nessuno mi prenderà per farmi diventare un uomo!… Poi volò via… Fu questa l’ultima volta che Wendy, la piccola Wendy, vide Peter’. E poi? Poi Peter Pan finì ammazzato da un colpo di moschetto italiano, o da una bomba a mano ‘Ballerina’: sul monte Grappa, alla fine della prima guerra mondiale. Non ci credete? In cima al Grappa. Nell’ossario monumentale che raccoglie i resti delle decine di migliaia di soldati italiani, tedeschi, austriaci, ungheresi, bosniaci morti tra quei monti, c’è un loculo misterioso, nel settore ungarico: “Soldato Peter Pan”, è inciso nel bronzo. (…) La Croce Nera austriaca, che conserva a Vienna tutti i dati dei caduti austroungarici, su Peter Pan ha una cartelletta quasi vuota: ‘Peter Pan, nato nel 1897 a Riszkabanya-Krassoszöreny, Ungheria. 30° reggimento di fanteria Honved, 7 compagnia. Morto in azione il 19.9.1918 a Col Caprile, quota 1.331”.

Qui sta la differenza sostanziale: se furono tanti i ragazzi ancora senza barba che morirono nella Grande Guerra, mandati al massacro da una generazione di adulti, in Favolacce la situazione si ribalta: sono i bambini e le bambine, silenti e consapevoli, a decidere di sparire. Ma è proprio la radice di questo gesto a farci tornare al primo volo di Peter Pan, che dietro la maschera di avventure e capriole nell’aria, nasconde il “gran rifiuto”, l’unico davvero possibile.
Meglio l’Isola-che-non-c’è, un’isola dei morti travestita da parco dei divertimenti. L’alternativa è descritta dallo stesso Barrie, impietosa pur dietro l’affabilità del tono: “Anche gli altri ragazzi erano cresciuti, ma non vale la pena parlare troppo a lungo di loro. Potete vedere i gemelli, Pennino e Ricciolo recarsi tutti i giorni all’ufficio con l’ombrello e una cartella di cuoio sotto il braccio. Michele fa il macchinista. Piumetto ha sposato una nobile fanciulla ed è diventato lord. Vedete quel giudice in parrucca che esce da una porta di ferro? Quel giudice era una volta Zufolo. Quel signore con la barba, che non sa raccontare ai suoi bambini nemmeno una favola, è Gianni”.
C’è una linea evidente di continuità tra il catalogo di questi destini e i personaggi adulti del film dei D’Innocenzo. L’unica differenza è data dal fatto che se ai tempi di Barrie l’aspirazione e la classe borghese aveva ancora una sua solidità, ora mostra tutte le sue crepe, non è più sostenibile, non c’è sacrificio che può giustificarne il prezzo. Lo sguardo dei due registi in questo si fa lucido, spietato, chirurgico, e sta tutto nello squallore di villette a schiera che ammiccano a una raggiunta posizione, a fabbrichette di sapone che non rovinano la pelle a quegli stessi bambini ai quali non si sa neppure rivolgere la parola, a salotti con moquette e tappeto come a volerle doppiamente nascondere quelle crepe, a barbecue dove la carne va di traverso e il boccone che non si riesce a sputare è quello di un’esistenza, a piscine esibite al vicinato e squartate poi in un disvelamento notturno. Non è un caso che l’unico ragazzino che si salva sia il figlio del personaggio che sembra meno interessato a farsi e a mostrare una posizione, ha ancora radici popolari, punta semplicemente alla sopravvivenza. Figura grottesca, certo non invidiabile per l’orizzonte limitato che incarna, pure ha conservato una sua insopprimibile vitalità, il suo corpo si muove scomposto e quasi comico, irrefrenabile sullo schermo, come la sua lingua che si traduce in un instancabile soliloquio che continuamente sollecita il figlio, non si cura dell’assenza di risposte, si aggrappa ai fragili sorrisi che ogni tanto riceve.
L’altro corpo veramente presente nel film, (mostrato per pezzi che via via la macchina da presa ci mostra a definirne i contorni) anch’esso ingombrante e impresentabile agli occhi piccolo borghesi della comunità, è quello della ragazza madre, esistenza alla deriva, eppure l’unica che in qualche modo, tra contrattazioni economiche, grottesche profferte sessuali, insulti e volgarità instaura un dialogo con uno dei piccoli ed è interpellata da lui, forse perché ne sente comunque una vicinanza, riconosce una medesima incapacità ad adattarsi, e lo stesso coraggio a fare il grande salto.
Per il resto è silenzio. Il silenzio è un bisturi micidiale con cui il film incide l‘esperienza dello spettatore. Un silenzio vicendevole, che al di là delle eccezioni indicate, vive nei due sensi, a segnare una distanza abissale, quella stessa che separa Londra dall’Isola-che-non-c’è: gli adulti neppure concepiscono di poter davvero instaurare un dialogo con i figli, sono incapaci di chiedere una spiegazione anche quando trovano le bombe autofabbricate nelle camerette, al massimo li prendono a calci. Il mutismo dei ragazzini e delle ragazzine, sottolineato dalla forza dei primi piani e dal sapiente uso della voce fuori campo, è già il segno di una scelta, di un rifiuto radicale ai modelli che si trovano davanti, e che non danno mai il segno di un’alternativa, di una via d’uscita. D’altronde sanno bene che le loro voci non potrebbero essere ascoltate. Si limitano così a recitare a soggetto, leggendo pagelle dai voti ineccepibili o scartando regali e ringraziamenti a un compleanno, prontamente ripresi per immortalare il momento, e poi lasciare di nuovo spazio al volgare parlottio dei grandi, vuoto e ingombrante allo stesso tempo.
Questo silenzio distanzia Favolacce da Peter Pan, nella tonalità più che nella sostanza. Il romanzo di Barrie ha la capacità di mascherare la sua natura mortifera con la vivacità del gioco e dell’avventura, di una affabulazione che ha ancora la vitalità della fiaba e del racconto, il film invece sembra vicino a romanzi come Un gioco da bambini di Ballard o L‘ultima ora di Dufossé. E non importa che in un caso siano i più giovani a uccidere con fredda sistematicità i genitori e nell’altro sia una classe di una scuola media francese a progettare un suicidio collettivo di fronte a un insegnante non stupido né insensibile, ma incapace comunque di trovare un qualche canale di comunicazione: entrambi sono ritratti impietosi di uno stato di afasia cronica tra generazioni. Ed essa inquina anche la relazione tra coetanei, ancora tenera quando si mescola all’impaccio dei primi innamoramenti, tristemente grottesca quando si traveste già del vocabolario adulto.

Infine c’è il tempo, quello che in Peter Pan si ferma e che qui invece sembra annunciarsi: siamo nell’estate alla fine della prima media, siamo all’estate con la “E” maiuscola, quella del passaggio, della pubertà. “Chissà se mi innamorerò anche quest’estate” recita la voce fuori campo mentre legge il diario ritrovato di una delle ragazzine morte. Sembra il segno di un’apertura, di un desiderio che contempla ancora una curiosità e un futuro. Esso trova anche un momento di incarnazione, quando il film si sofferma su una battaglia con i gavettoni e i corpi, la giovinezza, le risate, il rincorrersi occupano lo schermo e lo sguardo dello spettatore, con una pienezza senza ombre, se non fosse che un rallenty (simile in questo a quello di un altro film sulla pubertà: Picnic ad Hanging Rock di Peter Weir) fa venire il sospetto di un’eternizzazione, di un’ultima immagine prima della scomparsa. Ma questo tempo proiettato in avanti, esplorativo, ben presto si trasforma nell‘orizzonte di un’esperienza chiusa: “facciamo sesso anche noi, così abbiamo fatto tutto” dice una ragazzina all’amico. Lo stesso che confesserà in un momento di debolezza, o in uno strenuo tentativo di lanciare un ponte verso i più grandi, di aver fabbricato una bomba: “così finisce tutto”.
Questo “tutto” così ribadito sembra davvero il segno dell’esaurimento di una possibilità di crescita, di una propensione in avanti, la negazione dell’avventura: “cresceva già morta la ragazzina” sentenzia la voce fuori campo che legge il diario ritrovato. Rimane da capire quando scocca il primo rintocco. Una delle più efficaci lacune del film è quella che tace sul momento della decisione di farla finita. L’innesco concreto è chiaro ed è nell’ultima lezione del professore, altra figura che ancora parla ai ragazzini e ha una autorità e influenza ai loro occhi: accusato e licenziato da scuola per aver (involontariamente?) provocato la costruzione delle bombe chiede di poter fare un’ultima lezione e si trasforma nel Pifferaio di Hamelin, sa che la vendetta più dura contro chi lo ha disprezzato è portarsi via l’infanzia.
Ma c’era ancora? La sua è una reale istigazione o semplicemente lo strumento concreto per portare a termine un piano già meditato? E quanto nel suo gesto c’è della logica adulta della vendetta o della compassione per un destino che già si conosce e nel profondo si condivide?
Viene in mente Pascoli, autore nel 1897 de Il fanciullino, altro manifesto della centralità che avrà l’infanzia nel secolo a venire, ma anche de L’aquilone, canto funebre e riconoscente alla morte bambina:
“Meglio venirci ansante, roseo, molle
di sudor, come dopo una gioconda
corsa di gara per salire un colle!
Meglio venirci con la testa bionda,
che poi che fredda giacque sul guanciale,
ti pettinò co’ bei capelli a onda tua madre…
adagio, per non farti male”.
I ragazzini e le ragazzine di Favolacce sono deprivati anche della possibilità di “venirci ansanti”: a loro è negato anche il diritto dell’ultima corsa.
—
Questo articolo è apparso sul numero 77 della rivista Gli Asini, uscito a luglio 2020. Per abbonarsi alla rivista e sostenere Gli Asini: gliasinirivista.org.






 Immagine di Bianca Bagnarelli
Immagine di Bianca Bagnarelli